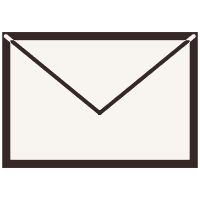Edizioni L'Atelier
4 Gennaio 2026, 00:21
Edizioni online - L'Atelier
Nino Chiocchio, "L’alba dei travetti e il crepuscolo dei travetti"
Capitolo XIV - In ufficio
Redazione
Quando Travetti rientrò in ufficio era stanco e nervoso. Era finita la pacchia! Prima se la prese con un povero usciere che non si sapeva fare gli affari suoi mentre trasportava i fascicoli da una stanza all’altra: quel poveraccio tirava la carretta, insomma lavorava, anche se per via di una certa invadenza non la sapeva tirare bene, la carretta. Poi il vacanziere si calmò nel leggere una lettera dei genitori, i quali lo esortavano a vivere la vita nel lavoro, nel sacrificio, nelle rispetto delle norme civili e morali..: “E’ meglio nobilmente oprare e soffrire, e così meritare”. A questo punto rifece pace con l’usciere tanto che una sera, avendo lui perso il pullman su cui poteva rientrare al suo paese, Enzo lo riaccompagnò a casa con la sua Peppinella. Più tardi lo rabbonì completamente un caro collega di un’altra sezione, Luigi, chitarrista ed ottimo disegnatore. S’era specializzato nel disegnare le caricature degli altri impiegati: sul tavolo aveva alcune macchiette. Leonardo era a mezzobusto ed aveva il collo tozzo, abbondante, tale che non lasciava spazio al resto della persona sulla paginetta striminzita, troppo striminzita perché potesse ospitare la di lui vignetta in modo accettabile. Aveva un gozzo ch’era simile ad una pera in posizione orizzontale più che ad un pomo d’Adamo; il mento pronunciato esprimeva uno spirito fra l’ascetico ed il polemico e sembrava tradire una certa allergia al pagamento delle tasse. Le labbra avide, pareva che fossero pronte ad accogliere un dito di grappa e mezz’etto di miele, una miscela tanto gradita a lui e che ben si attagliava al pasticcio dei baffetti suoi. Il naso, eufemisticamente aquilino, era volitivo nella chiara espressione di pertinacia; ma evocava anche gagliardia e ...reazione, almeno agli occhi di pernice che, diceva, lo affliggevano. Invece quelli veri, gli occhietti vispi e furbi, protetti da capaci borse, alternavano lampi di luce a livide stoccate grifagne che spesso si smorzavano in uno sguardo turbato, rivelatore di una profonda sensibilità. Le sopracciglia, simili al grado capovolto del caporale, si muovevano in perfetto sincronismo con la tonalità delle occhiate. La fronte spaziosa si addiceva ad un intellettuale di rango. I capelli irti, molto simili agli aculei del riccio, evocavano la rivoluzione francese. Il collo corto, proporzionato alla statura fisica, si sarebbe ben piazzato su un piedistallo di marmo. Il lettore avrà già sentenziato che a Travetti piaceva poco lavorare, dal momento che si interessava a troppe cose estranee alla sua normale attività, che era quella dell’impiegato. Invece no! L’Ufficio era ben organizzato e lui lavorava come si conveniva ad un giovane che sapeva fondere l’entusiasmo per le cose serie (o semiserie) con l’esuberanza degli anni ruggenti in una dimensione serena che gli rendeva agevole lo svolgimento dei compiti affidatigli, pur nel pieno rispetto di tutti i doveri: e questo indipendentemente dalle raccomandazioni epistolari dei genitori. Pretendeva, anzi, che anche colleghi e collaboratori facessero il proprio dovere. Perciò un’altra volta redarguì lo stesso usciere che aveva cacciato in malo modo una professoressa anziana, la quale chiedeva di essere sentita per motivi veramente urgenti in un giorno non riservato al ricevimento del pubblico; ma lo difese, qualche giorno più tardi, quando quello negò l’ingresso al nuovo titolare dell’Ufficio, il quale, senza presentar le credenziali, veniva a prender servizio in sostituzione del suo collega trasferito: in quella circostanza il nuovo capo dovette presentare il decreto di nomina e solo allora passò; e senza le scuse...
L’arrivo del nuovo capo avrebbe potuto scombussolare l’imminente “ponte” programmato da Travetti per i primi di novembre; invece non fu così: un po’ perché il primo era ancora preso dai problemi personali collegati al trasferimento, un po’ perché il secondo non offese mai la dignità professionale relativa al nomignolo che gli aveva simpaticamente appioppato S., cioè “architetto”.
Firenze - Nella metà degli anni ‘60 una sorella di Travetti era impiegata a Firenze, ove spesso lui la andava a trovare. Nell’autunno del 1966 era andato lì, con i genitori, e vi si trattenne qualche giorno; presto i cupi nuvoloni di quel giorno precedente al diluvio, che incombevano sulla città, lo consigliarono a ripartire con tutti i suoi cari, compresa la sorellina. La pioggia cadeva minuta e insistente, noiosa: pure le pietre incastonate in Piazza della Signoria erano viscide e tetre, a monito, si sarebbe detto, del sacrificio di frate Savonarola. Seguitò monotona, con la stessa cadenza, fino alla Certosa del Galluzzo. Poi aumentò. Stavano scampando al tremendo diluvio imminente[1]. Attraverso il parabrezza era appena possibile assistere allo spettacolo offerto dall’autostrada che stava diventando una lunga palude, coperta com’era uniformemente da un sottile e sporco mantello liquido. Le gocce parevano echeggiare i battiti di quei pezzettini di cuore ch’erano rimasti a Fiesole, che palpitavano su Ponte Vecchio, che non erano voluti uscire dalla bottega artigiana delle riproduzioni del David e della Pietà Rondanini, che s’erano fermati a San Miniato, a Boboli, alle Cappelle Medicee, al San Giovanni, a Santa Croce, al mercato delle paglie e nei chiassi del centro che sarebbero stati devastati qualche ora più tardi dalla furia delle acque. Quando arrivarono a Roma seppero che Firenze era stata oltraggiata, che cinque formelle della Porta del Paradiso giacevano sotto il fango che aveva coperto Piazza Duomo, che anche il tratto autostradale della Val di Chiana era divenuto più praticabile alle barche che a Peppinella[2]. Restava la speranza che il David scendesse dal piedistallo e fermasse quell’iradiddio; intanto Enzo stimò opportuno non provocare più, da quel momento, la sorella col tessere le lodi dei monumenti teatini, paragonandoli a quelli della città del giglio, a lei tanto cari. Appena le fu possibile, la sorella di Travetti, travetta presso la Biblioteca Laurenziana, tornò nella città-scrigno, la povera città che nella sfortuna ebbe la fortuna di essere soccorsa da tanti volontari[3], da tante forze giovani (fra cui vanno annoverati tanti impiegati, colleghi di Travetta), attratte dal fascino e commosse per la sorte di tanti tesori d’arte. La sorella di Travetti calzò un paio di stivaloni e, via, col primo treno che ristabilì i collegamenti con Roma! Poi, dopo diversi giorni, scrisse al fratello una lettera in cui erano così realisticamente, così plasticamente narrate le vicende di quei giorni da suggerire un parallelo con la lucreziana descrizione della peste: “Caro fratello, scusami per la grafia, ma qui il riscaldamento non funziona ed il freddo e l’umidità ti uccidono. Se vedessi come è disfatto il volto di Firenze! Si rifarà, dicono quelli che credono di conoscere i gravi problemi che affiorano ovunque; certo, le ferite si rimargineranno, ma quante cicatrici segneranno il corpo[4] di questa Città! Quanti tesori s’è portato via l’Arno fangoso e puzzolente di nafta! Mi è impossibile ora fare l’elenco dei danni. Quel che mi sembra certo è che non abbiamo perso soltanto il Cristo di Cimabue; e pensare che soltanto quel Cristo è già tanto, è troppo! E le due testine di leone della porta del Pisano al Battistero, alcuni documenti del glorioso Gabinetto Viesseux, la raccolta di strumenti musicali del Museo Bardini, i bellissimi corali ricchissimi di miniature del Museo dell’Opera del Duomo, il modello della Chiesa di San Firenze, gli affreschi di Paolo Uccello, la parte bassa di alcuni affreschi di Giotto, la raccolta di giornali dall’indipendenza d’Italia ad oggi... quante cose l’Arno impazzito ha offeso o distrutto! Chi è lontano non vede e non puó capire: io ho potuto comprendere la sciagura che si è abbattuta sulla città appena sono arrivata. Brancolavo nel buio, fra la melma mista a detriti di ogni dimensione, e di tanto in tanto battevo contro ostacoli vari: montagne di cose ormai rese inservibili e tavole che puntellavano i muri pericolanti di alcune case. Ma soprattutto ho avuto idea della vastità del disastro il giorno dopo, quando sono andata al quartiere di Santa Croce, dov’è la Biblioteca Nazionale. Già a prima vista mi fece paura vedere tanti mezzi militari nella piazza e nelle vie circostanti: sembrava di essere in guerra! Le ruspe e le gru rimuovevano e raccoglievano immensi mucchi melmosi in cui si vedeva la poltiglia ch’erano diventati gli oggetti strappati all’uomo: libri, quadri, pezzi di mobili, stracci, e mille cose trascinate su un fiume di melma dalle case e dai negozi letteralmente sventrati. Una scrivania con la macchina da scrivere ed alcuni fogli furon visti galleggiare per tutta via dell’Agnolo fin quando si persero giù in fondo, dietro l’angolo della strada. Un topino fu visto annaspare disperatamente finché fu travolto dalla corrente. I vestiti ed un manichino di una “boutique” di fronte alla casa dove abito indugiarono un po’ nel vortice formatosi davanti alla vetrina, poi si misero a navigare al seguito delle forme di formaggio provenienti dalla pizzicheria accanto insieme ai polli di un’altra bottega. E la gente dalle finestre dei piani alti guardava attonita lo spettacolo incredibile dell’Arno che scorreva per le vie ad una velocità finanche di settanta chilometri all’ora. Sai che nei primi giorni si facevano le catene di voci che da finestra a finestra trasmettevano le notizie fino a farle giungere in Questura, in Prefettura, ai pompieri? E gli aiuti non potevano arrivare! Gli abitanti dei primi piani, svegliati dall’urlo del vento e dalle grida di chi si chiedeva se fosse arrivata la fine del mondo, avevano fatto appena in tempo a scendere dai letti, le cui sponde erano già lambite dall’acqua, ed avevano trovato rifugio nei piani più alti. Il signor T. s’è visto gonfiare ed aprirsi il pavimento della stanza donde cercava di portar via qualcosa: l’acqua premeva dagli scantinati cercando uno sbocco che non riusciva a trovare. Un libraio della zona di Santa Croce (fra le più colpite), non avendo presagito tutta la rabbia del fiume, ha trasportato sui tavoli del grandissimo magazzino le cose di maggior valore che gli è riuscito di trovare; poco dopo è stato trasportato in spalla via di lì, e due giorni più tardi, quando l’acqua s’era ritirata e soltanto il fango ristagnava nelle case e per le strade, nel vasto magazzino c’era rimasta una cortina compatta di materiale viscido e bavoso depositatosi fino a dieci centimetri dal soffitto. In via M.Palmieri, l’acqua ha raggiunto e superato quattro metri. Pure, i Fiorentini non hanno perso la loro arguzia e quasi trovano un motivo di distrazione alle loro pene nel raccontar di quel vecchietto che aveva salvato il televisore e che poi, essendo scivolato ed avendo perso l’equilibrio mentre attraversava un ponte, raccolse l’apparecchio tutto inzaccherato e, affacciatosi sul fiume, lo scagliò ed esclamò con rabbia: “Te tu m’hai preso tutto, te tu t’hai a prendere anche questo, ovvia!” Tutto questo succedeva mentre un fornaio passava per la via Ghibellina (dov’è la casa di Michelangelo) sulla porta del suo panificio, divenuta una provvidenziale zattera anche per il vecchietto, mentre vogava con un grosso manico di scopa e distribuiva alla gente affacciata alle finestre i pani ch’era riuscito a salvare prima che l’acqua, dopo aver scardinato la porta stessa, penetrasse all’interno.”
Coloro che hanno calunniato e calunniano gli impiegati, tutti gli impiegati, soltanto perché appartengono a quella categoria, ebbene quegli individui abbiano rispetto almeno per quelli che (come fece la sorella di Travetti correndo da Roma a Firenze, appena le fu possibile, ed esponendosi volontariamente all’umidità ed a tutti i disagi causati dall’alluvione per salvare i libri della Biblioteca Nazionale, lei che era in congedo e che prestava un diverso servizio in un diverso luogo della città) hanno dimostrato di saper lavorare con abnegazione per la collettività; non guardino ai travetti (in questo caso il termine è appropriato, se gli si vuol dare un significato spregiativo) che si trovavano nella città sfortunata nei giorni della calamità e che, appena poterono, si rifugiarono in luoghi confortevoli con la scusa che il servizio a cui erano addetti s’era interrotto. O, i denigratori che hanno molti travetti fra loro, giustificheranno questi ultimi? Il che è anche possibile, considerato che una ventata apocalittica tenta di sconvolgere - da un secolo irrobustendosi sempre più - le mentalità.
[1] Il 4 novembre 1966 l’Arno ruppe gli argini e inondò Firenze con una piena d’acqua e di fango. La sera del 3 Crescenzo, ch’era lì con i genitori da un paio di giorni di pioggia insistente, fiutò il peggio e se ne tornò con tutti i suoi nella megalopoli.
[2] L’automobile di Enzo.
[3] La solidarietà umana si esaltò anche allora nel volontariato.
[4] Vanna era molto affezionata a Firenze per le tante ferite inferte ad una città oltraggiata come una creatura cara.