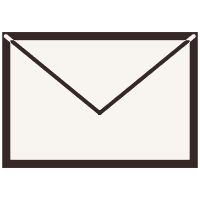Chieti e Provincia Edizioni L'Atelier
25 Gennaio 2026, 06:42
Edizioni online - L'Atelier
Nino Chiocchio, L’alba dei travetti e il crepuscolo dei travetti
Capitolo XVII - San Liberatore
Redazione
È bello vivere a pieni polmoni il ritorno della breve estate autunnale. Decisamente San Martino avrebbe meritato una maggiore considerazione. E non solo perché si tagliò la ricca cappa per dare un mantello al viandante povero; che poi è il cielo pulito della bella stagione, quella fresca di primavera che sembra voler mettere in ordine le cose che s’erano dilatate pel rumore mondano e per la calura estiva. La parentesi tiepida non invita solamente a sognare: s’apre al fresco respiro che scende dal cielo azzurro anche per evocare l’atmosfera monastica che permeava ancora i muri di una vecchia chiesa e dei ruderi affondati nel verde secolare. Serramonacesca è un paese appollaiato alle falde della Maiella; da lì (la descrizione è di allora) parte una mulattiera tortuosa che si perde in una macchia biancastra stampata nel fianco della montagna. E’ l’abbazia di San Liberatore della Maiella di cui ora resta la chiesa, che né i restauri dell’epoca rinascimentale né l’abbandono né le intemperie hanno alterato nella struttura originaria. Era stata eretta intorno al Mille, ma i caratteri della prima architettura romanica abruzzese, dopo le calamità, assunsero rilievo nella geometria della volta a cassettoni, con il tetto digradante sugli agili contrafforti che portano l’edificio -davanti, a sinistra- fin sotto le trifore del moncone del magnifico campanile quadrangolare. L’affresco dell’abside ha cercato di resistere all’usura del tempo ed alle crepe del muro. Di lì partono le navate, che si allungano solenni fino alla facciata, rifatta, su cui una volta si apriva il portale (a quel tempo custodito nella chiesa di Serramonacesca). Fuori, sul breve sagrato che s’inerpica verso l’erta montana, alcuni pini neri par che veglino sulle povere croci e sulla pace invocata dai monaci sui casolari sparsi negli sterpeti vicini. Incastonato lassù, nel mistero del bosco e nella quiete della montagna, accarezzato dallo sciacquio del torrente Alento, quel luogo di raccoglimento è un inno sublime che le cose create innalzano al Creatore. Quella volta l’incantesimo fu rotto da un rumore improvviso ed assordante. Quando Crescenzo e G. salirono pei tornanti con Peppinella e poi si andarono a fermare sotto l’ingresso dell’austero campanile, quell’inno si mutò in un frastuono terrificante che annichilì gli insoliti visitatori, gli intrusi: era lo sbatter d’ali di un rapace disturbato nella quiete del nido che s’era costruito nella torre campanaria.
Il trasferimento di G.- Era la giusta premessa del giorno seguente, quando piansero pure i cuori di G. e dei suoi amici. La piemontese aveva ottenuto il trasferimento a Torino, e molti di quelli, gli amici, quando partì, la accompagnarono alla stazione di Pescara. Lei promise che sarebbe tornata a rivedere gli amici di tante avventure, e così poi fece; ma intanto se ne andava. Se ne andava triste, senza l’accompagnamento di quei canti che erano stati intonati tante volte; se ne andava senza scene patetiche, ma col magone che ognuno cercava di nascondere senza successo. Se ne andava una creatura esuberante che aveva saputo contemperare in maniera brillante l’esigenza del rispetto degli impegni professionali con la spontanea e volitiva partecipazione alle vicende degli amici abruzzesi. Motivo di consolazione: finalmente avrebbe trovato il tempo per tradurre dalla lingua francese i testi di filosofia per conto di un noto editore.
La partenza di Giulia suggeriva pensieri tristi, tanto che parve più pietoso del normale l’incidente stradale, avvenuto lo stesso giorno, simile nel luogo e nella dinamica a quello che ad Enzo aveva suggerito “Manoppello fatal”, avvenuto in quei giorni; questa volta c’erano stati i morti, l’incidente volle le sue croci. E queste furono simboleggiate, al margine della strada, da grossi mazzi di fiori; poi i fiori appassirono, poi quelli che avevano deposto i fiori ripresero a vivere la vita di tutti i giorni, anche quella frivola dei festivals. Poveri morti! Forse erano passati discreti fra noi e forse avevano lasciato insegnamenti che ora si traducevano in un ricordo che magari appassiva con i fiori... Le croci vere, intanto, sia quelle nascoste fra l’erba e i fiori, sia quelle che ancora svettano sulle opere sepolcrali, protendevano nell’azzurro i moncherini prima che le stringesse la morsa del gelo e le ammantasse la fredda coltre bianca o, nell’altra stagione, fossero immobili sotto il sole implacabile dell’estate torrida, dell’estate che per i vivi diluisce l’afa negli ozi della villeggiatura. E poi? E poi tutto scorre... Giulia era partita.
La slitta- L’estate di San Martino si era dileguata, con discrezione e con una certa fretta, tanto per rispettare la breve durata che le assegnava il calendario. Insomma aveva ceduto il posto alla stagione fredda: cadde la neve, la manna degli sports invernali.
Partirono di buon’ora. Su Peppinella viaggiavano Enzo, Lucio e due giovani professoresse (una apparteneva alla nostra “confraternita” e l’altra era una collega di colei). In quel mattino spensierato di una fredda domenica si stemperavano i riflessi dei ghiacci della montagna nel timido azzurro d’un cielo velato che poi lassù, sulle vette, aprì la cappa turchina delle giornate splendide, quelle giornate che nella stagione fredda sono ideali per gli amanti della neve. Sull’automobile erano stati montati gli sci per i giovani; le ospiti, che non sapevano sciare, sapevano però respirare l’aria fina e, all’occasione, magari avrebbero affittato uno slittino, come poi fecero. Allo “Scoiattolo”, l’albergo dove trovò le slitte e prenotò il pranzo, la comitiva incontrò un medico dell’Ospedale Militare, un medico amico, il quale nel giorno festivo non pensava che avrebbe dovuto esercitare la professione anche in montagna, dove era salito con la giovane moglie per distrarsi dopo una settimana di lavoro. Torniamo ai quattro. Questi, dopo essersi rifocillati e attrezzati, si avviarono verso le vicine piste abbondantemente innevate. Crescenzo salì ancora un poco e le assaggiò in lungo e in largo: erano comode, si scendeva un po’ in diagonale e un po’ disegnando ampi tornanti sulla neve ghiacciata dei fianchi della montagna. Giunto a valle, il nostro montava su un piccolo autocarro egregiamente attrezzato perché ancora mancava un impianto di risalita. E sciava, e si divertiva; e non si divertiva di meno quando, allorché passava accanto agli amici, li trovava quasi sempre allo stesso punto: si arrabbattavano a volte con gli scarponi e a volte sugli attrezzi per sciare. Finalmente Lucio riuscì a fare una specie di discesa dopo avere a lungo traccheggiato con uno sci che voleva correre quando l’altro non era ancorato allo scarpone di competenza. Anche le ardite fanciulle si provarono a scivolare con gli slittini ma, forse pensando che, sistemandosi entrambe su un solo mezzo, sarebbe stato più agevole farsi coraggio reciprocamente, abbandonarono gli slittini, ritenuti poco governabili, ed optarono per una slitta grande che quindi le accolse tutte e due. Mio Dio, perché cambiarono? In fondo non è vero che lo slittino sia poco governabile: la slitta grande, in quel caso, si risolse in un fatto psicologico. E senza dubbio per tutte e due fu una pena congiunta a dolore: per chi non sa muoversi sulla neve è pericoloso anche montare una slitta. Se non avessero cambiato, l’incidente sarebbe accaduto soltanto ad una di loro(?); così andarono a sbattere tutte e due contro una roccia che non si era scansata quando vi precipitarono sopra. Da lontano Enzo si accorse che qualcosa non andava per il verso giusto e dirottò verso lo spuntone calcareo. L’urto doveva essere stato violento: Lucio, il quale stazionava nei paraggi della slitta, restò inebetito a guardare. Che cosa? Poi disse di non essersi accorto che il diavolo (o la botta) aveva spaccato il cavallo dei calzoni della nocchiera. Ma chi ci rimise seriamente non fu costei; fu l’altra, l’amica, che rimase con un braccio penzoloni fino a quando Crescenzo la portò con l’auto giù, in albergo, dove intanto per fortuna era sceso quell’ufficiale medico a cui si è accennato; il quale, forse per gustare e far gustare i maccheroni de Lo Scoiattolo agli amici, esaminò il polso della ragazza e parlò di contusione; in realtà quello era rotto e poi restò ingessato per quaranta giorni!