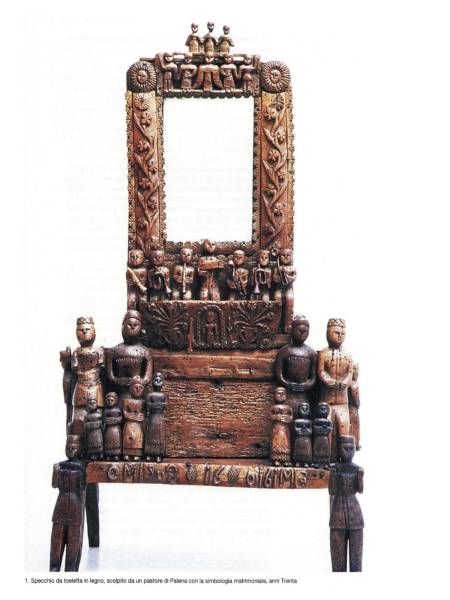Abruzzo Elzeviri
17 Giugno 2025, 06:36
QUANDO SULLE NOSTRE MONTAGNE LA PRODUZIONE COLTA SI CONIUGO’ CON LA CREATIVITA’ DEI POETI PASTORI, ARTIGIANI E STORIOGRAFI
Nino Chiocchio
Il titolo emerge dalle letture sulle gesta dei paladini. Non mi riferisco, però, al conte di palazzo del ciclo di Carlo Magno, all’eroe di Roncisvalle, bensì all’umile protagonista della poesia dei tratturi, anzi, dell’epopea dei tratturi, il quale portava nella bisaccia i libri che raccontavano le imprese fragorose e fantasmagoriche di quel notabile: il nostro Vate aveva incontrato i transumanti da bambino nelle scorribande con gli amichetti da Pineto a San Vito; allora Pescara ancora confondeva il suo nome con quello di Castellammare e al futuro Poeta era stato facile paragonare al “piano” il “tremolar della marina”. Probabilmente poi, da giovane, seguì i pastori anche in montagna; quelli, prima di giungere sul litorale, avevano affrontato enormi sacrifici come, alcuni anni prima, era accaduto al piccolo Jurico (lo vedremo più avanti).
“E van per il tratturo antico al piano/ quasi per un erbal fiume silente / su le vestigia degli antichi padri…”
I rozzi “gentiluomini” per millenni, fino a quasi un paio di secoli fa, accompagnarono le miti greggi, incolonnate in pittoresche carovane costellate di altri animali domestici quali cavalli, possenti cani-pastore, ecc.: la coreografia pastorale ispirò, sul litorale adriatico, il piccolo “Rapagnetta” nel senso che movimentò con un forte cromatismo un paesaggio di per sé suggestivo. I pastori ricalcavano le “calles” romane dove erano impresse le “vestigia”, cioè il patrimonio culturale dei predecessori che avevano arricchito la loro sapienza con la frequentazione di territori sconosciuti, con i loro misteri, con le loro vicende, con i loro usi, ma che avevano pagato queste ricche acquisizioni con lauti baratti, con le sofferenze di esiliati stagionali, di avventurosi ed eroici contadini, confluiti in mandrie sempre più numerose esprimendosi con parlate diverse, costretti a difendersi dall’assalto di belve affrontate con il bastone chiodato da cui prese il nome “l’arte della mazza”. E come non bastasse, superando ostacoli naturali imprevisti anche quando la temperatura corporea non era normale; anche quando dovettero usare la clava di “avellana” chiodata contro i “latrones” (gli antichi banditi); anche quando condivisero con qualche pellegrino con la conchiglia un tratto di percorso; anche quando, dopo il Mille, i pastori divennero nello stesso tempo mercanti di chincaglierie, attività poi, dopo il 1447, rinforzata dall’industria della lana.
Nelle epoche gravitanti attorno ai cosidetti “secoli di ferro” (900-1100) le antiche calli furono calpestate e insanguinate dalle invasioni barbariche e dalle ondate saracene, per cui solo qualche pellegrino coraggioso riuscì a superare le disavventure aprendo un orizzonte sereno su quelli che sarebbero diventati poi i tratturi.
E anche, in quel tempo e nell’immensa area già illuminata dalla civiltà romana, diciamo nel mondo conosciuto di allora, le religioni furono travolte dal turbine. Da noi la religione cristiana, la quale si espresse con una tempera dorata sullo spirito solidale di una società smarrita, era ancora in crisi per via dei primi riformatori, fra cui San Domenico di Sora, a cominciare da papa Gregorio VII, per cui il timone della Storia, cioè tutte le religioni, sbandava tra scismi e eresie; e però questo ostacolo fu superato da quello spirito solidale che fu alimentato dalla carità cristiana con iniziative e rappresentazioni metaforiche.
Nel XII secolo un gruppo di monaci (Agostiniani?) aveva costruito nei pressi di Pamplona un ospedale, poi un ricovero ed una chiesa onde lì, sul cammino per Santiago di Compostela dove sarebbe avvenuto lo scontro tra i cristiani e i mori (770 d.C.), ospitare poveri e pellegrini di passaggio. Per la cronaca, il paladino caro a Carlo Magno, sarebbe stato seppellito nella chiesa annessa. Immaginiamo che un pellegrino peligno, divenuto tale dopo che le avversità gli avevano cambiato la vita pastorale, abbia sentito parlare, lungo il cammino, delle gesta di Orlando e dei paladini.
Prima di arrivare nella vicina città di Sulmona, percorrendo la strada provinciale sannitica (i luoghi descritti ricalcano l’antica calle che a sua volta ricalcava la deviazione della prima Tiburtina-Valeria del 356 a.C. da Collarmele a San Benedetto, poi a Pescina, a Cocullo e Sulmona, per dirigersi verso il Sannio, poi denominata Via Numicia) venendo da Cocullo, arrivati sotto le mura di Porta Romana, una deviazione a sinistra porta ad un punto in cui ci si imbatte in una chiesetta, appartenuta all’Ordine degli Agostiniani e intitolata a Santa Maria di Roncisvalle, a ricordo della Vergine, lì venerata e dove i pellegrini sostavano prima di giungere a Santiago di Compostela: qui, ubicata sul cammino che collegava il Tratturo regio, il pellegrino-pastore provocò la erezione di un “ospitale” che divenisse ricovero per i suoi colleghi e ospizio per i bisognosi. Poco distante un fontanile. In proposito diversi studiosi riferiscono che in quel punto sarebbe avvenuta una triste scaramuccia fra abitanti di Sulmona e abitanti di Pescocostanzo con una sanguinosa vendetta effettuata l’anno seguente dai Sulmonesi: un gruppo di pescolani, avrebbe oltraggiato donne sulmonesi durante un pellegrinaggio. La leggenda, che fra l’altro ci giunta in diverse versioni, è stata trasmessa oralmente ad un cronista del ‘500 (il quale comunque pare che abbia attinto ad una tradizione secolare pervenutagli oralmente), ha tutte le caratteristiche delle notizie tramandate, cioè manipolazione, trasformazione, alterazione, spostamenti di epoche e luoghi, né specifica il contenuto ed il significato dell’“oltraggio”. L’anno dopo, in occasione della fiera di Santa Maria di Roncisvalle, i Sulmonesi si sarebbero vendicati aggredendo i Pescolani, facendo una strage (trecento persone uccise) e offendendo la dignità delle loro donne. Però, possiamo affermare che qualcosa successe; quel che lascia perplessi è innanzitutto la vendetta covata per un anno (826-827); quindi sproporzione fra le premesse della vicenda e la conclusione orrenda della stessa. Sorvolando sulle tradizionali controversie tra centri limitrofi, fermo restando che dovette verificarsi un accadimento serio, la cui memoria è stata tramandata nel tempo sotto metafora, accenno a qualche fatto d’interesse storico che si verificò in secoli lontani magari anche con la confusione dei protagonisti: 1- nel 1200 Pietro del Morrone fu consacrato papa a L’Aquila, scendendo dalla vicina Maiella, per cinque mesi e, quando abdicò per tornare all’eremo della Badia sulmonese, non poté realizzare il progetto in quanto il suo successore (Bonifacio VIII), temendo un eventuale scisma per la popolarità da cui era circondato Pietro, cioè Celestino V, glielo impedì; 2- più di un secolo dopo il signore di Pescocostanzo, ma poi anche di Anversa (sei chilometri da Cocullo) era Jacopo Caldora, prima capitano di ventura e, in età avanzata, secondo marito di Jcobella, l’ultima contessa di Celano della linea Berardi-Ruggeri. Il Caldora nella maturità seguirà attentamente la disciplina della transumanza: il fatto a cui ho accennato sopra sarebbe avvenuto accanto al fontanile del “passo” tratturale Celano-Foggia. E allora perché non pensare che la molla dei tumulti non sia stata un abigeato?; 3- sin dall’Alto Medioevo si teneva a Pamplona la fiera di Santa Maria di Roncisvalle il 1° di settembre, retaggio della festa di San Firmino; a Cocullo nel ‘600 si eleggeva l’amministrazione comunale nella chiesa parrocchiale di S. Egidio (rilevo la contemporaneità fra l’adempimento amministrativo e quello religioso: fiera-celebrazione religiosa); in verità, specialmente nell’arco di tutto il Medioevo, di fiere tenute il 1° settembre ve ne saranno state tante nei paesi e nelle città.
Quel che possiamo onestamente registrare è che ormai la religione si era saldata con la pastorizia transumante. Restiamo in Abruzzo e precisamente nel complesso tratturo Celano-Foggia. Partiamo da una pergamena di casa nostra, in cui peraltro non traspare l’esigenza spirituale bensì il senso pratico dei pastori-mercanti. Nell’Archivio del Municipio di Cocullo molti anni fa rinvenni una pergamena miniata purtroppo tagliata ai margini: per questo non posso affermare se la data sia stata abrasa o più semplicemente tagliata con le miniature; data che peraltro possiamo stabilire con approssimazione desumendola dalla durata della vita del nobile marchese di Pescara, Ferdinando Francesco d’Avalos (nato nel 1490, morto nel 1525), il quale l’aveva emanata su incarico del viceré, quindi nel primo ventennio del ‘500:
Ferdinando Francesco d’Avalos d’Aquino Marchese di Vasto, di Pescara, Principe di Francavilla, Conte di Loreto, Regio Collettore Consigliere, e consigliere di questo Regno di Sicilia, Gran Camerario, Luogotenente [e al presente ] della Regia camera Sommaria. A tutti e Singoli… omissis: funzionari e impiegati regi, funzionari e impiegati dei vassalli di questo regno, a tutti i percettori di gabelle, tasse, dazi, “di qualsivoglia sorte” di introiti, pedaggi nei posti di blocco, mastri giurati, appaltatori di gabelle dei luoghi di dette terre dei luoghi del presente Regno e segnatamente: omissis…e Tutte altre Città, Terre e luoghi di tutte le Prov.e del p.sente Regno. In q.sta R.a Cam.a si è comparso p. parte de Giovanni Ant.o delli Sciotto, Bartolomeo Colucci e Nicola colucci e son (1) della Terra di Cocullo pre. e figli, suoi Compagni e Garzoni dell’arte di bamacignari e me ha[ve fatte] Intendere Come Sogliono andare In altre Città, Terre, Castelle, Ville, fiere, Mercati, Campi, Perdonanze et altri luoghi del p.sente Regno Comprando vendendo, et barattando…omissis… quali trouano à uendere et à Conprare, barattare quali preinserte robbe, e Cose uts.a, e le portano dentro le Sporte, Sportoni, Sacchetti, Fascetti, e zaijni, e Sacchi […… ]altro Modo Sopra lore persone, e trouandosi Stanchi per Strada pouero ammalato le possano portare Con Salme e che Voi Sopranominati Officiali Dohanieri arrend.ri Credenziari, passaggieri, piazzari, et Guardiani delle Dohane e passi, omissis…
Con la p.sente […]iamo, ordinamo, et espressam.te Comandamo ancorche non possino prenarrati ut s.a a tutti, e singoli officiali del p.sente Regno tante Regie Come de Baroni dirne ogni uolta che accaderanno li sudetti Gio. Antonio delli Sciotto, Bartolomeo, Lonardo e Santo o Suoi Figli di Cocullo, suoi Compagni, et Garzoni dell’arte de lazz… […sin]gole di uendere, comprare, barattare, et passare p. q.que urbana Jurisdittione, et Luoghi Con le prenominate robbe Sopra loro p.sone, e spalle, q.elle vendendo, Comprando e barattando (2), et In ogn’altro Modo non trattenendoli, li debbiate trattare et fare passare, uendere, Comprare et barattare e dimorare Senza esserne tenuti [..doman]dare Licenza alli Capi delle Città e Terre et altri Luoghi… omissis … Ordinandomo a Tutti, et singoli offitiali maggiori et Minori, tanto regij Come de Baroni, e Ciascheduno In loro Iurisdittione, che Cossi faccino …
La lamentela riguarda i mercanti cocullesi i quali avevano ricorso perché si sentivano angariati dalle continue imposizioni di gabelle da parte dei vari feudatari.
Già altrove (v. “Le pergamene di Cocullo”) avevo scritto quanto segue:
… furono emanati un po’ dovunque analoghi bandi per ammonire notabili e prepotenti ingordi…: a Vasto il signore, nel 1499, prescrisse la libertà di commercio: “… piaccia non impedire ne prohibire alli mercanti et homeni di detta Terra le loro mercantie et industrie, ma quelle possano liberamente li detti homeni comprare, vendere, extraere per mare e per terra ogni generatione de mercantie, pagando lo loro debito et solito diritto…”. Tuttavia ancora un secolo dopo (1594) questi ordini erano inascoltati se il Luogotenente e i Presidenti della Regia Camera della Sommaria scrivevano: “… Per parte della Università et particolari de Scanno, locati de la Regia Dogana de le pecore n’è stato esposto che nel calare che fanno in Puglia con lloro pecore et animali che teneno sotto la Regia fida, et nel ritornare sono molestati et astretti li particolari patroni de detti animali, et li loro garzoni, Galgari et guardiano a pagare li passi, piade decime et altri pagamenti, de li quali in virtù de li privilegii et concessioni sono franchi et immuni. Ne hanno perciò fatto supplicare….OMISSIS… Per questo ordiniamo che debiate trattare li pand.3(3) de d.a terra de Scanno, loro gargari franchi da qualsivoglia pagamento de piazza, passo con loro massarie, pecore et altri animali fidati in Dohana, tanto nell’andare como nel ritornare, et anco nel condure che fanno le robe, lane, casci et pelle pervenute da dette pecore de dogana, et per li panni che portano fatti da lane di d.e pecore fidate…”.
Note
1 - Sembra che l’estensore in un primo tempo abbia scritto “persone” e poi vi abbia sovrapposto “e sone”.
2 - Qui elenca le cianfrusaglie, troppe perché lo spazio disponibile mi consenta di citarle tutte (“toccati”=fasce o fili intrecciati; “rezziglie”=reticelle per i capelli delle ragazze; “bambace”=cotone di scarto; “bagnìa”=pania; “puntilli”= marchi, punzoni; “pezzilli”=merletti, trine; “acora”=aghi; “spingole”=spille; “bèrcole”=straccali, bretelle; “armacolli”=cinghie, gorgiere; “paternostri” e “grone”=rosari; “granatelle”=perline; “scioccagli”=orecchini; “cannacche”=collane… Alcuni di questi termini, chi più e chi meno alterati dalle dimensioni temporali e geografiche, sopravvivono in certi dialetti; altri – es. “banìa seu rete per ucelli” - sono svaniti con le abitudini scomparse)
3 - “pannacciari”, venditori di panni.