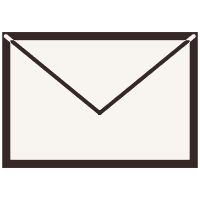Italia Cultura
2 Novembre 2024, 07:16
La poetessa dei Navigli amante delle vecchie osterie
Antonella De Santis
«A me piacciono gli anfratti bui delle osterie dormienti» scriveva Alda Merini, che 15 anni fa ci ha lasciato dopo una vita furibonda di amore e dolore eterni. Un'esistenza raccontata a piene mani dalla sua biografia in versi, lorda di vita eppure cristallina, scritta per intervalla insaniae e poi diventata cronaca di una città che Merini ha vissuto, straripante, da quei Navigli di Milano che tanto ha amato. Dove è nata in via Mangone, a Porta Genova, «il 21 di primavera» dell'anno 1931 quando quella «era una zona nuova ai tempi, di mezze persone, alcune un po’ eleganti altre no» e dove ha vissuto a più riprese, in famiglia prima e poi in solitudine, nelle tregue concesse dalla guerra e dagli abissi del manicomio. Alda Merini e la sua famiglia erano «poveri in canna». Si sposa presto, a un certo punto con il marito prende una panetteria in via Lipari, non facevano il pane, lo vendevano soltanto: «Mi chiamavano la fornaretta» racconta a Cristiana Ceci nel 2004. Sono ricordi sbiaditi, ma la fame d'amore e di cibo accompagnerà Alda Merini per tutta la sua vita nella casa in Ripa di Porta Ticinese dove è rimasta fino all'ultimo, nell'indigenza e nell'accumulo che le faceva segnare i muri come taccuini, sopraffatta dalle robe che raccoglieva e custodiva, nella stanza oggi smantellata e ricostruita altrove, a memoria della poetessa dei Navigli.
I Navigli di Alda Merini
Quanto era diversa la Milano di allora. C'erano le osterie «dove la gente culmina nell’eccesso del canto». Difficile immaginarla adesso tra i Navigli afflitti dalla vita notturna, incastrati tra gli Spritz e i taglieri gonfi di salumi. All'epoca si percepiva ancora l'eco di una vitalità popolare, sempre più bohèmien, sempre meno proletaria. E infatti Alda cominciava a guardarla con sospetto: «Non l’amo più Milano. È diventata una belva che non è più la nostra città. Adesso è una grassa signora piena di inutili orpelli». Chissà cosa direbbe ora di quei luoghi su cui ha tracciato la sua geografia sentimentale, in cui trovava rifugio dall'angoscia: «a me piacciono le cose bestemmiate e leggere, e i calici di vino profondi, dove la mente esulta, livello di magico pensiero» e poi ancora «io amo le osterie che parlano il linguaggio sottile della lingua di Bacco». Era la lingua che dava tregua alla solitudine: «Troppo sciocco è piangere sopra un amore perduto malvissuto e scostante, meglio l’acre vapore del vino indenne, meglio l’ubriacatura del genio, meglio sì meglio l’indagine sorda delle scorrevolezze di vite». E altrove: «O vino che canti il mio dolore, vino che sei il precipizio estremo, vino che dai l’illusione della morte e fai solo dormire fino al nuovo dolore».
La immaginiamo Alda Merini con le sue collane e la sigaretta accesa, a sbirciare nei locali alla buona: «Ieri sera nel basso dentro la gioconda osteria un uomo trangugiava il suo vino con una voluttà bacchica e assente, io guardavo la sua gola turgida di vino e dimenticanza e mi chiesi come mai mi tenessi in cuore una spina senza chiedere aiuto a Bacco». E torna in più punti, la presenza salvifica delle osterie quando la tavola domestica si è trasformata in deserto: «La mia cucina da anni non è più calda, non ci mangia più nessuno». Non ci sono più gli affetti a tenerla lì: «Io mi nutro con un panino, rovesciata sul letto, guardando pareti da cancellare. Non potrei più desinare in cucina senza mio marito e i miei figli. Se faccio tardi ceno anche in piccole trattorie, ma è la stessa cosa. Quando torno a casa non c’è nessuna pentola che bolle intorno». Nessuna cucina sia nel silenzio dei sentimenti.