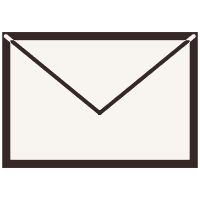Edizioni L'Atelier
28 Dicembre 2025, 11:09
Edizioni on line
Nino Chiocchio, L’alba dei travetti e il crepuscolo dei travetti
XIII Capitolo - Il richiamo dell’affetto famigliare alternato alle vacanze
Redazione
I genitori di Enzo, ancora in ottimo stato di salute, nella stagione fredda vivevano soli nella casa romana. Avevano tre figli: Nunzia (Titty), Enzo e Vanna, in ordine di età. Dopo il ’62 la prima figlia insegnava ancora al paese natio dove si era stabilita creando una nuova famiglia (avrebbe raggiunto e insegnato qualche anno dopo nella capitale); Enzo e Vanna erano impiegati rispettivamente a Chieti e a Firenze. Titty doveva adempiere ai doveri dell’insegnante, quindi a vivere nella regione abruzzese, ovviamente le sue visite ai genitori non potevano essere frequenti, mentre Enzo e Vanna, che vivevano nell’appartamento dei genitori, si accordarono che avrebbero alternato il ritorno a Roma alternativamente nei giorni festivi.
Per raggiungere la capitale Enzo spesso percorreva la “Tiburtina-Valeria”, l’antica via consolare che è bella e varia, sia quando s’incassa nel cuore delle vallate ricche di vegetazione, sia quando par che s’inerpichi sui prati delle montagne. Quella volta imboccò la “Salaria”[1], non meno suggestiva, specialmente nel mese di giugno, allorché la natura ancora lussureggiante ti circuisce con i suoi aromi e con i colori d’un vestitino gallese blasonato, fra le cui pieghe i fringuelli gorgheggiano melodiosamente sul tema della primavera. Prima Scandriglia era il nome di un paese diviso in parti uguali fra un cartello della segnaletica stradale e le pagine agiografiche di un antico cronista religioso, perché anche lì, attorno al Mille, un eremita[2] costruì un cenobio o qualcosa del genere; allora, a giugno, il cartello indicava un santuario della natura immerso nel verde. Insomma quello scorcio della Sabina era bello e interessante.
Vacanze con l’acuto delle Tremiti- Anche Giulia era tornata in anticipo dalle sue vacanze torinesi. Forse era ricomparsa perché Crescenzo le aveva scritto che lei, andandosene, ne aveva fatta un’altra delle sue e che s’era portato con sé il brio con cui aveva animato la confraternita; e le ricordò le insenature della spiaggia abruzzese nonché l’episodio accaduto fra le voragini della Maiella, quando una voce bianca del nostro coro era stata trascinata da un’esigenza fisiologica dietro un cespuglio, proprio sotto la scritta, a caratteri cubitali di pietra “...la Maiella madre guarda e benedice”. Poi arrivarono le vacanze vere, per tutti, anche per Travetti, il quale andò in montagna. Ma sentite che succedeva in un ufficio ben organizzato prima delle ferie. Le carte trovavano rapidamente la via giusta: quando non andavano ad ingrossare la catasta degli “Atti”, si esaminavano con una solerzia insolita. Poi si evadevano e si affidavano al loro destino. Quando arrivavano le vacanze, si era pronti a farle ed a gustarle. Non era difficile gustarsi le vacanze: il primo segreto era nascosto in quell’”essere pronti”, cioè nel non dover lasciare arretrati; un altro segreto consisteva nell’alternare il rifugio del paese natìo (qualunque paese natìo, specialmente in Italia, è bello!) con piccole evasioni culminanti in un attento giro turistico di una determinata località e con il ritorno al paese per un meritato riposo, che puó anche far posto all’otium classico. Così la pensava Travetti; d’altra parte poi arrivavano le vacanze coincidenti con le stagioni lavorative... Tornò al paesello e gustò la prima settimana festiva tra i suoi, nella quiete del borgo e nel calore della sua gente. Poi si presentò fresco e riposato all’appuntamento vacanziero con gli amici.
Stupendo! Erano in sette. Con Crescenzo c’erano Giustino, Bruno, Tonino dell’Aquila, Vanna, Maria ed Anna: una comitiva formidabile coordinata da un organizzatore formidabile, Giustino. Partirono da Pescara di buon’ora e puntarono a sud, su Vasto e Termoli, graziose cittadine litoranee in cui si avvertivano le prime pulsazioni del mattino. Prima di arrivare a Campomarino attraversarono immense distese costellate di angurie e di zolle nere. C’è terra nera, laggiù, terra nera e frutta in abbondanza: quanta frutta, e quanto buona! Ma non si vedeva neanche un’abitazione. Pareva che terra e mare non volessero essere turbati dal cemento, dato che non si vedevano neanche i rari casolari disseminati nei campi vicini alla costa: forse si vedeva qualche rudere emergente da un altro mare, quello delle frutta. E in fondo, appena percettibile oltre l’azzurro del cielo, un bastione di colline. Finalmente apparvero alcune casette basse. Poi ancora monotone teorie di terreni coltivati variamente a frutta, tutti coltivati comunque a frutta, nello sfondo grigio di baluardi evanescenti. Qualcuno della brigata, forse qualcheduna un po’ devota e un po’ curiosa, aveva suggerito di puntare all’interno per salire a San Giovanni Rotondo, il santuario dell’ancora vivente Padre Pio. San Giovanni Rotondo era (allora) un grosso borgo rurale, con pretese cittadine, ad economia “agricolo-religiosa”. Si arrampicarono per una via fiancheggiata da edifici che gareggiavano nell’ostentare nomi e insegne di santi che sfilavano in rapida successione: loro ragione sociale[3] era, “Pensione S.Giacomo”, “Alloggio S.Gaetano”, “Albergo S.Giuseppe”, ecc. Arrivarono ad un moderno complesso edilizio sviluppatosi intorno ad un minuscolo e scolorito convento adagiato alle falde della montagna. Le tre gitanti erano vestite con la decenza che permettono le gite (in ogni modo l’abbigliamento di quel tempo era più castigato di quello di oggi): non indossavano il cilicio; tuttavia, se ne avessero avuto la possibilità(!), probabilmente si sarebbero presentate nel luogo sacro vestite con abiti austeri. Purtroppo un clima d’intensa spiritualità popolare, non disgiunto dal rigore di una specie di fanatismo religioso, non tollerava i fazzoletti variopinti delle turiste, quasi che la stoffa colorata fosse motivo di profanazione. Le poverette tornarono dal santuario come i pifferi del proverbio: biascicarono qualcosa, ma gli uomini non capirono granché, anche per via della riservatezza femminile. Tutti capirono, però, che la sosta devota volgeva al termine.
La “foresta d’umbra” è bella! La raggiunsero in pochissimo tempo e vi sostarono a lungo, anche per consumare una colazione al sacco (che fame!) e per giocare a pallone fra gli alberi secolari. Le ragazze andarono a vedere il recinto dei caprioli. La comitiva ebbe degli ospiti occasionali, forse richiamati dalla chitarra di Tonino e dal violino di Enzo nonché dalle belle canzoni abruzzesi. La foresta non concede spazi ai raggi del sole: qualcuno, fra i più audaci, riesce a spingersi tra le foglie fino a spegnersi fra i rami più bassi. La foresta d’umbra non si poteva chiamare con un termine più appropriato: è un’ombra immensa che ammanta quasi tutto il tacco della Penisola per ritirarsi dolcemente con le chiome degli alberi sulla costa rocciosa fino a lambire la lastra limpida del mare turchino.
Sbarcarono a Vico Garganico, una grossa borgata quel giorno colorata e frastornata dai festeggiamenti in onore del taumaturgo; poco dopo percorsero uno dei più begli itinerari d’Italia: Peschici, San Menaio, Rodi Garganico. Quante carrube colsero lui e Tonino vicino a quei golfi trasparenti da cui emergevano, come palafitte, le ombre di enormi tronchi d’albero! Arrivarono a Rodi Garganico con la prima oscurità della sera. Rodi era un delizioso paesetto di pescatori, di qualche agricoltore e di tanti calcestruzzi bianchi. Enzo non riuscì a dimenticare i calcestruzzi della casbah, dove pure trovò qualche ospitalità. Per riposare le membra si arrangiarono tutti in alloggi di fortuna; le donne e gli uomini sposati ci andarono meglio poiché trovarono due comode stanze in un edificio non più recente, situato al centro del paese ed echeggiante nella struttura certe caratteristiche delle moschee. Lui e Tonino andarono a finire vicino al porto, nel cuore di uno di quei quartieri arabi dove aleggiano l’esotismo e il mistero. Fra i ciottoli radi delle viuzze, che si perdevano sotto archi alti e stretti, sgusciavano figure guardinghe e curiose accanto ai gradini e ai muretti bassi e bianchi. Fu là che Enzo e Tonino trascorsero la prima notte della gita, una notte caratterizzata dal rumore degli zoccoli di un asino impaziente che era alloggiato nel vano accanto al loro (e dire che la camera dove avrebbero dovuto dormire i due era la stanza da letto dei padroni!): il che indusse i due giovani a fissare gli occhi per tante tante ore, da una piccola finestra, sul cielo stellato. La mattina seguente il nostro ebbe modo di rilevare che lì l’acqua non correva nei rubinetti in tutti i momenti della giornata, e che per lavarsi la faccia occorreva comprare il liquido incolore. Il cesso puzzava tremendamente e il turista fu costretto a fare le pulizie del gatto. Quando gli fu possibile, si lavò più volte, con l’acqua dolce e con quella salata, ma non riuscì tanto presto a liberarsi del fetore che gli si era ficcato fra le narici e il cervello (Tonino e Enzo, turbati dal rumore degli zoccoli asinini, si alzarono di buon mattino e si sfogarono nei campi vicini riempiendo la macchina di Tonino con tante carrube). Avevano ormai lasciato la terraferma. Sulla nave si divertirono con la chitarra e con le carte da gioco. Vanna fotografò una bambina veneta che, accovacciata dentro un oblò, guardava pensosa i “merletti” verdi che si raccoglievano a frangia intorno allo scafo: sembrava, quella fanciulla incastonata nell’oblò, una rosa sbocciata in un prato esotico lievitato nel liquido azzurro. Sbarcarono al largo dell’isola di San Domino, che raggiunsero in barca. Dopo aver affrontato una salita ripida si ritrovarono in una breve radura posta ad una trentina di metri sul livello del mare; l’orizzonte era delimitato dalla vegetazione che spuntava folta da un immenso piedistallo di scogli e rocce friabili. Là, sul grosso macigno che grondava verde sull’orizzonte terso del mare, il cuore si gonfiava e la fantasia si esaltava affidandosi al volo pieno e tranquillo dei gabbiani. Due scogli, grossi e piatti, emergevano dallo specchio d’acqua in cui si stemperavano i colori della tavolozza delle Tremiti; quello di San Nicola si adagiava come una tozza torre biancastra, con quelle sue case di calce che dialogavano con i raggi del sole fino al limitare della costa rocciosa. Sotto il profilo amministrativo l’isola allora era il centro più importante dell’arcipelago. Gli dissero che c’era un sindaco; ci saranno stati pure un prete e un farmacista, un becchino e fors’anche un calzolaio. La vista del grosso penitenziario che dominava l’abitato non lo invitò a visitare quell’isola. L’isolotto della Capraia sonnecchiava tutto glabro. Era vergine: l’unico elemento estraneo, un triplice cavo elettrico, ne sfiorava appena la superficie su cui si saldava l’impasto marrone con quello azzurro del cielo e del mare. Sotto la cala, lungo la costa, di fronte a San Nicolò, s’insinuavano una turgida vena turchina ed una vela minuscola; più oltre sembrava apparire un lembo di terra immacolata, sulla cui reale esistenza, ancora oggi, non si potrebbe giurare.
Purtroppo anche le gite belle hanno una durata, altrimenti non belle sarebbero. La via del ritorno, dopo che si son visti certi luoghi, provoca sempre qualche fastidio al fegato: Enzo non cantava più; salvo che in occasione di due soste, a Termoli ed a Vasto (per gustare squisite zuppe di mare), restò sempre sdraiato sul sedile posteriore di un’automobile, mentre nel crogiuolo della fantasia si alternavano Peschici e San Menaio e Vieste con le stupende visioni della “foresta d’umbra” e dei colori di quella terra immersa nel palpito azzurro che si fonde col turchino infinito. A Pescara la comitiva si sciolse ed Enzo tornò con la sorella in paese, dove i due raccontarono le bellezze delle Tremiti e della Foresta d’umbra. Soltanto Peppinella non riposò troppo; aveva ripreso abbastanza fiato durante l’assenza del padrone. Ora non le faceva male un po’ di rodaggio pei tornanti del Parco Nazionale, prima del ritorno alla base teatina.
Fine della 13.a puntata
[1] Oggi le vecchie consolari son quasi del tutto sostituite dall’autostrada, allora inesistente.
[2] Domenico di Foligno, in onore del quale una volta ogni primo giovedì di maggio in un paese dell’Abruzzo aquilano si svolgeva la famosa processione con i serpi.
[3] Oggi che P.Pio è stato beatificato forse le ragioni sociali sono aumentate; ma in quel tempo il fenomeno era frenato, considerato che la proliferazione suggerì ad un Papa l’emanazione di disposizioni volte ad evitare inopportune speculazioni.